Indice dei contenuti
Leggere il corpo-mente disabile: la visibilità obbligata come dispositivo di oppressione
di Julia Arena
Fiorire nel buio: custodire il glitch tra i silenzi di foreste digitali
di Vittoria Martinotti
Divrse forme di alterità: Annie Ernaux e il corpo assente
di Amanda Rosso
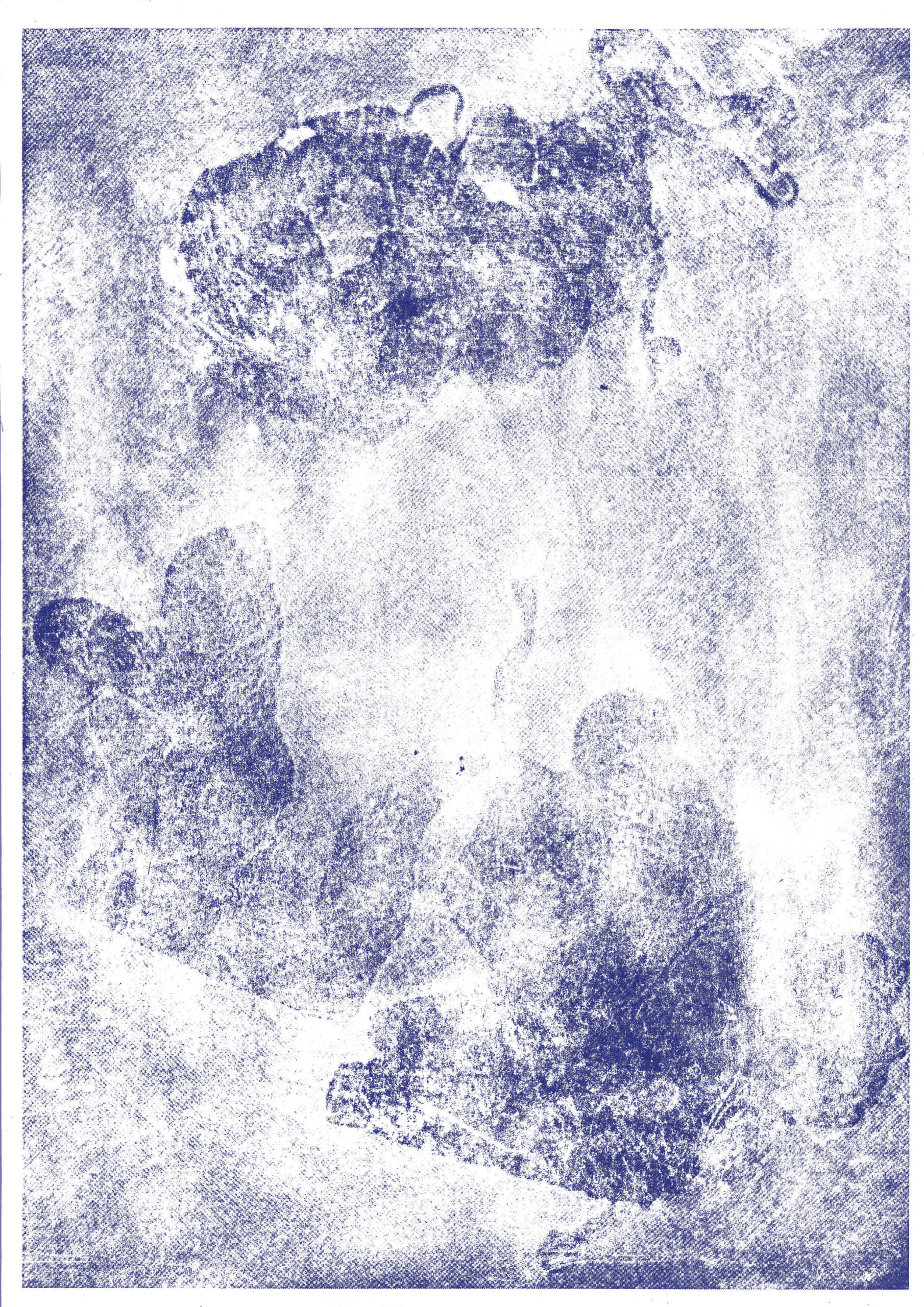
La secolare lotta delle donne e persone marginalizzate per affermarsi come soggetti narranti, piuttosto che oggetti narrati, ha trovato terreno fertile nella possibilità di immaginare un sé edificato attraverso il linguaggio. Nell’ambito della narrazione autobiografica, l’interazione tra emancipazione e reificazione diventa una questione centrale quando si prendono in considerazione i media visivi.
L’idea barthesiana che una fotografia autentichi l’esistenza del suo soggetto1 suggerisce che possa tanto immortalare una presenza quanto implicare un’assenza. Inoltre, sebbene la «presunta veridicità dell’immagine fotografica sia stata da tempo messa in discussione»2, il potere della fotografia risiede proprio «nell’indeterminatezza del suo riferimento al mondo»3, qualità che condivide con l’autobiografia. In questo contesto, il corpo diventa il luogo di diverse costruzioni culturali e storiche, piuttosto che un’entità fisica autonoma e univoca. Pertanto, sebbene sia innegabile che una volta catturato, sia tramite un’immagine che tramite un testo, il corpo venga sottoposto a scrutinio, il genere autobiografico consente «un esercizio di controllo sull’immagine di sé»4, poiché chi scrive stabilisce i termini della narrazione, i contenuti e le modalità della rappresentazione.
In un testo, quindi, le fotografie svolgono molteplici funzioni: talvolta sono prove, altre tracce, altre ancora diventano specchi o portali verso altri momenti e luoghi all’interno della narrazione principale. Per questa ragione, in virtù della loro natura eterotopica – ovvero della capacità di esistere all’interno di spazi convenzionali pur contestandoli e rispecchiandoli – le fotografie permettono la costruzione di un racconto di sé inteso come pratica di «autorappresentazione»5.
Il concetto di eterotopia è stato elaborato a metà degli anni Sessanta dal filosofo francese Michel Foucault, che lo utilizza per descrivere spazi dotati di molteplici livelli di significato in relazione ad altri luoghi. Eterotopiche sono infatti realtà «in cui gli spazi reali […] sono al tempo stesso rappresentati, contestati e sovvertiti»6. Centrale per il concetto di presenza e assenza del soggetto nello spazio eterotopico è lo specchio, «una sorta di ombra»7 che riflette la visibilità.
Foucault scrive: «[g]razie allo specchio, scopro di essere assente dal luogo in cui sono, poiché mi vedo là»8 .
Trovo che l’esperienza ambivalente della presenza e dell’assenza, dell’ombra e della visibilità, del sé reale e dell’immagine riflessa, sia centrale nell’esperimento “fotobiografico” di Annie Ernaux, L’usage de la photo, scritto insieme a Marc Marie. Come scrive Susan Sontag, fotografare «significa appropriarsi della cosa fotografata. Significa porsi in una certa relazione con il mondo che somiglia alla conoscenza – e dunque al potere»9. Scattare una fotografia è, allo stesso tempo, affermare la propria presenza nell’azione e rivendicare il diritto di selezionare ciò che si ritiene importante; in altre parole, avere il controllo della narrazione. Cosa accade, quindi, se la fotografia viene usata per nascondere invece che per rivelare?
Ne L’usage, Ernaux si trova a negoziare le contraddizioni insite nella rappresentazione di sé come donna soggetta allo sguardo patriarcale. Nell’opera, infatti, la relazione tra testo e fotografie consente una lettura del corpo di Ernaux in rapporto alla vulnerabilità della malattia e della passionalità – anch’essa talvolta vulnerabile – della relazione con Marie.
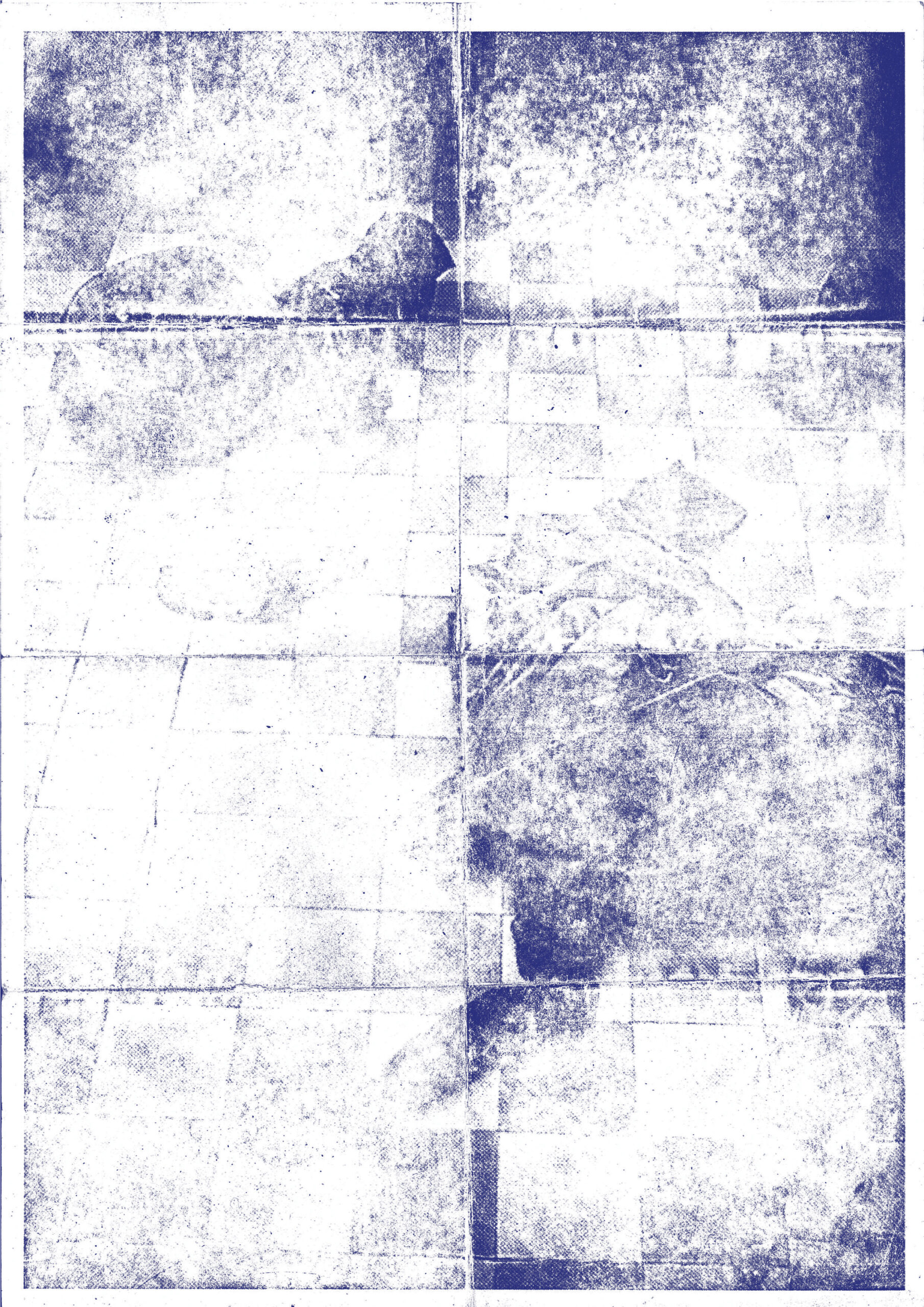
L’usage è composto da quattordici fotografie in bianco e nero (più una, descritta ma non inclusa) di interni, abiti scartati, fogli sparsi e mobili, scattate da Ernaux e Marie tra marzo 2003 e gennaio 2004, i dieci mesi della loro relazione e della chemioterapia dell’autrice. Le fotografie, scelte e realizzate insieme, sono accompagnate da didascalie che riportano luogo, data e talvolta l’orario dello scatto. Mentre le fotografie mostrano solo ciò che rimane dell’atto sessuale, è il testo a rivelare tanto la malattia quanto la passione. L’autrice opera una forma di conoscenza visiva di sé collocata «tra esposizione e mascheramento»10, attuata attraverso il gioco «tra affermazione e negazione del sé»11.
Il corpo, centrale e vulnerabile sia nell’atto sessuale che nel trattamento oncologico, non viene mai fotografato, ma viene narrato nel testo. In questo senso, l’equilibrio tra rivelazione e rimozione, esposizione e occultamento, viene realizzato attraverso l’uso delle fotografie, grazie alle quali Ernaux crea una sorta di autoritratto in absentia per mettere in discussione la referenzialità della fotografia rimuovendosi dagli scatti. Ne consegue che delegando la narrazione alla lettura testuale della fotografia, e sottraendosi all’obbiettivo, Ernaux tenta di conservare una forma di controllo sulla sua immagine, evitando una totale esposizione.
Lo sguardo di chi legge si sposta così dal corpo come oggetto di osservazione – «un teatro d’operazioni violente»12 – a Ernaux come soggetto narrante. Il corpo malato diventa così uno spazio intermedio tra salute e morte, che lei sceglie di rappresentare ed evocare ma non immortalare. In questo contesto, le fotografie le permettono di esercitare un controllo sul pubblico e sulla sua percezione, ridefinendo così il «privilegio epistemologico»13 che sta al centro della sua autorivelazione. Il corpo scompare ma viene messo in scena dagli abiti14, offrendo all’autrice la distanza necessaria affinché l’esperienza possa materializzarsi attraverso la scrittura. In tal modo, grazie all’uso di feticci, Ernaux elude il rischio di trasformarsi in «un oggetto completamente esposto alla lettura, interamente dipendente dal lettore per la costruzione del significato»15.
In virtù della loro natura eterotopica le fotografie diventano territori di autorappresentazione attraverso l’assenza, in cui malattia e sesso sono al contempo evocati, contestati e rinegoziati tramite l’interpretazione testuale. Poiché le fotografie dovrebbero simboleggiare l’atto sessuale senza rappresentarlo direttamente, le immagini lo evocano ma Ernaux si affida al testo per completare la narrazione. Come osserva Marie, le fotografie «rappresentano proprio ciò che non è mostrato: ciò che è avvenuto prima, durante e subito dopo»16. In questo caso, gli abiti incarnano una presenza resa visibile proprio attraverso la rappresentazione dell’assenza. Marie ed Ernaux sono assenti, ma altrove presenti. Le fotografie contengono così elementi eterogenei: gli abiti suggeriscono la specificità di un momento nel tempo e nello spazio, evocano la presenza degli amanti nel presente, e rimandano a un futuro in cui quegli abiti potrebbero essere gli ultimi resti dell’amore, le vestigia di una vita interrotta o vissuta.
Lo specchio eterotopico di Foucault si adatta perfettamente a Ernaux, che è al tempo stesso viva nel presente e potenzialmente morta in un futuro più o meno prossimo. Le immagini evocano così passione e morte senza mostrarle direttamente, permettendo la selezione e costruzione dei ricordi da preservare, proteggendo Ernaux dallo sguardo di chi legge.
A posteriori, l’autrice esprime una certa delusione nell’osservare che «[n]ulla dei nostri corpi resta nelle foto»17, quasi pentita, lei che della rivelazione del sé ha fatto una cifra stilistica, di quella ritrosia. Eppure, sottrarre il corpo all’obbiettivo ha permesso di potenziare il processo di «significazione straripante della foto»18 – la sua capacità di andare oltre il soggetto e l’intento iniziale. Senza la distrazione dell’umano e del corporeo, accostando piani diversi di realtà, le immagini lo nascondono e allo stesso tempo lo disvelano, rivelando l’afflato di vita nella morte incombente e anticipando la presenza della morte intrinseca alla vita. Se l’autobiografia «agisce come una sorta di testamento, mentre la fotografia di una persona viva entra negli archivi come prova di un corpo vivente, di un momento vissuto»19, le fotografie nel testo permettono a Ernaux di esistere sia come corpo malato che corpo desiderante, vivo e morto, presente e assente, narrante e narrato.
¹ Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, Jonathan Cape, Londra, 1982, p. 87.
² Natalie Edwards, Amy L. Hubbell, Ann Miller (a cura di), Textual and Visual Selves: Photography, Film and Comic Art in French Autobiography, University of Nebraska Press, Lincoln, 2007, p. 7. [Traduzione dell’Autrice]
³ Timothy Dow Adams, Light Writing and Life Writing, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2000, p. 15. [TdA]
⁴ Ibidem. [TdA]
⁵ Sidonie Smith, Julia Watson, Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2001, p. 14. [TdA]
⁶ Michel Foucault, Different Spaces, in James D. Faubion (a cura di), Aesthetics, Method, and Epistemology, The New Press, New York, 1998, pp. 175-186. [TdA]
⁷ Ibidem. [TdA]
⁸ Ibidem. [TdA]
⁹ Susan Sontag, On Photography, Penguin, Londra, 2008, p. 2. [TdA]
¹⁰ Helaine Posner, The Self and the World: Negotiating Boundaries in the Art of Yayoi Kusama, Ana Mendieta, and Francesca Woodman, in Whitney Chadwick (a cura di), Mirror Images: Women, Surrealism, and Self-Representation, MIT Press, Cambridge, 1998, pp. 156-171. [TdA]
¹¹ Ibidem. [TdA]
¹² Annie Ernaux, Marc Marie, L’usage de la photo, Gallimard, Parigi, 2005, p. 83. [TdA]
¹³ Eve Kosofsky Sedgwick, The Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley, 1990, p. 232. [TdA]
¹⁴ Akane Kawakami, Photobiography: Photographic Self-Writing in Proust, Guibert, Ernaux, Macé, Routledge, Londra, 2013, p. 112. [TdA]
¹⁵ Susanna Egan, Mirror Talk: Genres of Crisis in Contemporary Autobiography, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999, p. 212. [TdA]
¹⁶ Annie Ernaux, Marc Marie, L’usage de la photo, op. cit., p. 95. [TdA]
¹⁷ Ivi, p. 110. [TdA]
¹⁸ Ibidem. [TdA]
¹⁹ Linda Haverty Rugg, Picturing Ourselves. Photography & Autobiography, University of Chicago Press, Chicago, 1997, p. 26. [TdA]
Amanda Rosso (Sanremo, 1989) è una ricercatrice indipendente con un MA in Lingue Moderne e Letterature Comparate presso la Birkbeck University of London. Si occupa di scrittura autobiografica femminile, con un focus su temi di razza, genere, classe e sessualità. Scrive per Letterate Magazine e i suoi racconti sono stati pubblicati su riviste e antologie online e cartacee. Collabora inoltre con Malgrado le Mosche. È membro del Direttivo della Società Italiana delle Letterate (SIL), che promuove la scrittura delle donne.
